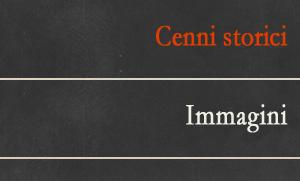IL GRADUALE DI SAN DOMENICO
Contenuti
Anche se conosciuto come Messale, il codice è definibile Graduale in base ai contenuti che sono il Santorale e il Comune dei Santi, ovvero i testi cantati durante la messa nelle feste dei santi più importanti dei quali ciascun incipit ha la lettera iniziale miniata.
Particolare rilievo è attribuito alla festa di san Domenico che è sottolineata da due miniature di grande ricchezza e qualità: la Gloria di san Domenico che occupa lo spazio dell’intera carta e il San Domenico in estasi e il frate orante che apre il verso successivo del canto.
La storia
Non esistono prove documentarie della sua provenienza ma una serie di corrispondenze rende del tutto probabile una sua origine nel convento di San Domenico di Fiesole. Al Museo di San Marco è arrivato dalla Biblioteca Nazionale a cui pervenne con la Biblioteca Palatina essendo venuto in proprietà di Maria Antonia consorte di Leopoldo II di Lorena in data imprecisata, forse come dono di nozze, dopo essere passato nella collezione del priore Ricasoli.
Le miniature
La ricca decorazione del codice, realizzata dal Beato Angelico con l’aiuto di alcuni collaboratori, comprende 29 iniziali miniate con storie o figure e 11 iniziali ornate da foglie. Le iniziali filigranate, invece, sono state eseguite da un “miniatore di penna” che si suppone sia stato Fra Benedetto del Mugello, fratello dell’Angelico, ricordato dalle fonti come “scriptor” e, quindi, probabile scriba del testo.
Attribuito all’Angelico già nell’Ottocento, il codice rappresenta una delle testimonianze più significative dell’attività del pittore durante i suoi primi anni nel convento di Fiesole alla cui rinascita contribuì anche con opere su tavola e in affresco. La sua realizzazione richiese, probabilmente, alcuni anni ed è situabile, proprio per gli stretti confronti con i dipinti, tra il 1424/25 e il 1427/28.
Il convento di San Domenico di Fiesole
Il convento fu fondato nel 1406 da Giovanni Dominici, uno dei primi riformatori dell’Osservanza. Rimase, tuttavia, incompiuto nel 1409 quando il primo nucleo di frati che lo abitava, fra cui Antonino Pierozzi, futuro arcivescovo di Firenze, canonizzato nel 1523, fu costretto ad abbandonarlo e a scegliere la via dell’esilio a Foligno. I frati, rientrati nel 1419, proseguirono la fabbrica con il lascito di Barnaba degli Agli, realizzando un convento e una chiesa più grandi che sarebbero stati consacrati nuovamente nel 1435. Ai primi anni dopo il rientro dei frati risale, con ogni probabilità, anche l’ingresso del Beato Angelico, allora Guido di Piero che, indossati gli abiti, prese il nome di Fra Giovanni, anche se non mancano coloro che ritengono la sua vestizione assai anteriore, ponendola al 1407.
San Domenico
San Domenico di Guzmán fu il fondatore dell’Ordine dei Predicatori, meglio conosciuto come Ordine Domenicano.
Il santo nacque in Spagna, nei pressi di Burgos, intorno al 1170 e morì a Bologna nel 1221. Compiuti gli studi in teologia e divenuto sacerdote a 24 anni, iniziò un percorso di missioni che lo portarono a contatto con realtà di povertà e di eresia, in particolare, fu mandato nel sud della Francia dove era molto forte la presenza dell’eresia catara. Il desiderio di evangelizzare le popolazioni, propugnando un ritorno allo stile di vita degli apostoli, lo convinse a fondare nel 1216 a Tolosa un nuovo Ordine, che prese come punto di partenza la Regola agostiniana, le cui comunità dovevano seguire una vita di fratellanza, dedita alla preghiera a allo studio. I frati che lo seguivano erano stimolati da Domenico stesso allo studio per essere più idonei a “parlare con Dio nella preghiera e a parlare di Dio nella predicazione”.
Non è casuale che le prime due città prescelte come sedi del nuovo Ordine fossero due città universitarie, Parigi e Bologna, a sottolineare l’importanza che lui dava allo studio come strumento indispensabile per l’evangelizzazione.
IL CICLO CORALE PER SAN MARCOIl convento di San Marco di Firenze
Nel 1436 i Domenicani riformati di San Domenico di Fiesole ottennero dal papa Eugenio IV il convento di San Marco, lasciato in condizioni rovinose dai monaci Silvestrini costretti a trovare una nuova sede. Grazie al generoso finanziamento di Cosimo e Lorenzo de’ Medici, il convento poté essere ristrutturato a partire dal 1437 ad opera di Michelozzo, l’architetto prediletto dai Medici, il quale profuse i nuovi ambienti del puro spirito rinascimentale fiorentino, espresso in una severa e rigorosa monumentalità.
La commissione medicea
La realizzazione del ciclo di libri corali completò il progetto di Cosimo a favore di San Marco, dopo la costruzione della biblioteca, finita nel 1444, e l’acquisizione del fondo librario di Niccolò Niccoli. Il ciclo ebbe inizio nel 1446 e fu pagato dallo stesso Cosimo, come testimoniano vari documenti, tra cui le note di possesso, i passi della Cronaca, gli stemmi medicei sulle legature e diverse iscrizioni presenti all’interno di alcune miniature dove Cosimo è indicato come “illustrissimus vir”. Queste sono rintracciabili nella cornice del fondo della lettera a c. 9r del Graduale 515 (Hos libros cives illustrissimus suis pecuniisque solu[...] et multa et magna beneficia et hoc templum extruxit Cosmas Med[ ...]); a c. 35v (Illustrissimus vir ac mana progenie cives Cosimus), c. 42r (Hoc Sancti Marci Monasterium fiorentina aci[...]n medico...) del Graduale 516.
L’uso dei corali
Ciascun codice era sostenuto dal badalone del coro della chiesa e veniva esposto durante l'anno a seconda delle festività celebrate durante la messa. Le grandi dimensioni dei Corali erano necessarie per essere letti, sia nei testi che nelle note (chiamate neumi), dai frati riuniti in coro.
L’iniziale miniata aveva la funzione, sia tramite la scena o la figura rappresentata, sia con i colori vivaci, di richiamare alla mente il testo e la musica.
I documenti
Nelle Ricordanze del Convento (BMLF, San Marco 902) sono registrati i pagamenti per la scrittura e per la miniatura del ciclo di libri corali. La scrittura venne eseguita, per la maggior parte, da Fra Benedetto del Mugello, fratello dell’Angelico, e dai francescani Frate Giovanni da Santa Croce e Frate Gianni di Guido Barbiere, anch’egli di Santa Croce.
La decorazione miniata fu realizzata da Zanobi Strozzi, per la parte figurativa, e da Filippo di Matteo Torelli per “i fogliami e oro e altri adornamenti”.
La legatura fu affidata a Vespasiano da Bisticci che, alla metà del Quattrocento, gestiva una delle più prestigiose legatorie fiorentine. Delle legature originali rimangono, sicuramente, i fornimenti metallici lavorati a traforo e incisione, tra i quali i bellissimi rosoni centrali con lo stemma mediceo. Di particolare originalità sono i rosoni dell’Antifonario 520 con la pergamena dipinta di azzurro come sfondo del traforo metallico.
Il corredo liturgico
Degli otto antifonari citati nelle Ricordanze, ne rimangono sette al Museo di San Marco, di cui cinque sono identificati; dei sei graduali documentati ne sono presenti otto, di cui sei identificati; di sei messali e quattro salteri presenti al museo, quattro messali e un salterio sono documentati; risultano, invece, mancanti un lezionario e un collettario.
La storia
I primi codici ad essere stati realizzati da Zanobi Strozzi sono gli Antifonari (Invv. 522, 517, 518, 520, 521), conclusi entro 1448; i lavori proseguirono con il ciclo dei Graduali (Invv. 515, 524, 528, 526, 527, 516) fino al 1454.
Le miniature
Le miniature che ornano le pagine del ciclo corale sono molto omogenee nella scelta delle misure, nelle impostazioni delle decorazioni a piena pagina, ornate dai fregi di Filippo di Matteo Torelli, nelle scelte cromatiche e nell'illustrazione delle feste principali con le iniziali con storie e figure, tutte riconducibili ai santi legati all’Ordine Domenicano.
Le iniziali appartengono a due tipologie, differenziate essenzialmente dall’uso della penna o del pennello per la loro realizzazione. Le “lettere di pennello” non contengono soltanto le scene figurate miniate da Zanobi Strozzi ma hanno spesso il fondo interamente occupato da decorazioni geometriche costruite con foglie e fiori miniato in modo del tutto omogeneo ai fregi delle iniziali figurate.
Le “lettere di penna”, chiamate filigranate per la somiglianza con la tecnica orafa della filigrana, sono caratterizzate dal corpo rubricato in rosso o azzurro e fesso da decorazioni a risparmio, mentre il campo quadrangolare e il fondo presentano decorazioni fitomorfe stilizzate di colore opposto al corpo.
Alcune iniziali filigranate grandi, presenti nel gruppo degli antifonari, possono essere definite di tecnica mista poiché hanno lunghe code che si estendono su tre o quattro margini con un evolversi di racemi fioriti e intrecci vegetali realizzati a penna e a pennello, e quindi sia ad inchiostro che a tempera.